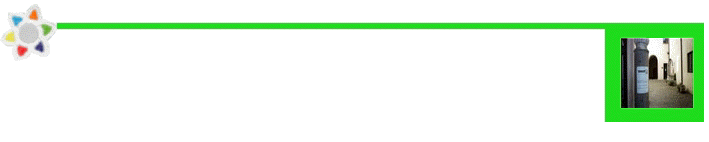
La preparazione
Un questionario è un metodo fondamentale per ottenere informazioni specifiche riguardo a un determinato problema, in modo che le risposte fornite, una volta analizzate ed interpretate, ne consentano una migliore comprensione. Nella progettazione di una ricerca è un elemento importante, e la sua preparazione richiede una considerevole capacità professionale.
Nella pratica, la redazione di un questionario è operazione estremamente difficile, anche se ad essa tutti ritengono di essere abilitati, e costituisce uno dei momenti più delicati di ogni ricerca.
E’ quindi opportuno, per non dire indispensabile, giungere alla formulazione definitiva passando attraverso numerose stesure provvisorie fino a giungere al test di una indagine pilota.
Le indagini tramite questionari possono venire eseguite secondo modalità diverse: è possibile utilizzare interviste personali, telefoniche, postali oppure autogestite dall’intervistato. Nella maggior parte dei casi, il questionario che l’intervistatore deve riempire si presenta sotto forma di una scheda. Il modo in cui è strutturato dipende dal metodo di indagine scelto e questo, a sua volta, è determinato dalla natura del problema su cui si deve indagare, dalle caratteristiche della popolazione di riferimento e dalle dimensioni del campione utilizzato.
Il modo in cui viene formulato un questionario varia all’interno di due tipologie di fondo che ne rappresentano gli estremi.
Da una parte troviamo un questionario altamente strutturato, composto da una serie di domande formalizzate proposte nel medesimo modo a tutti gli intervistati con lo scopo di ottenerne risposte a una gamma limitata di alternative (domande chiuse).
All’altro estremo si colloca il questionario non strutturato dove uno stile molto flessibile nel condurre l’intervista si sostituisce alle domande standardizzate (domande aperte). L’intervistatore in questo caso si comporta in modo da dar vita a una conversazione nel corso della quale gli intervistati sono invitati a rispondere liberamente a una serie di domande aperte, spesso formulate in modo da adattarsi alla persona che si ha di fronte.
Nella maggioranza dei casi, si opta per un metodo che comprenda entrambe le modalità di intervista. Ma, indipendentemente da questo, le singole domande devono essere predisposte in modo da indurre coloro che rispondono a fornire informazioni chiare ed aderenti alla realtà, il meno possibile distorte o in qualche modo errate.
Come si evince dalla esatta riproduzione della scheda proposta agli utenti del Comune di Troia si è utilizzato un questionario a domande chiuse con poche eccezioni riguardanti: le informazioni anagrafiche e gli eventuali suggerimenti per migliorare l’organizzazione comunale.
Le domande chiuse, alle quali l’intervistato deve adattare le proprie indicazioni contrassegnando la risposta che maggiormente corrisponde alla propria posizione, possono creare problemi a qualche intervistato quando le risposte standard non prevedano esattamente il suo pensiero. Forzando la risposta ad adattarsi ad una delle alternative previste, si può travisare il vero significato.
Per evitare questo effetto distorsivo in sede di preparazione del questionario, bisogna cercare di trasformare le domande aperte in domande chiuse ad alternativa semplice (Si/No) ed a scelta multipla cercando di prevedere tutte le possibili risposte.
Per essere sicuri che le alternative offerte dalle domande a scelta multipla consentano all’intervistato di esprimere correttamente il proprio pensiero è stato necessario compiere un attento lavoro di impostazione: le alternative devono innanzitutto escludersi mutualmente, in modo che chi deve rispondere sia in grado di distinguerle senza difficoltà.
Solo alla domanda 2. del questionario è stato aggiunto un codice per risposte insolite (Altro). Tale modalità di solito è analizzata in sede di elaborazione per tentare di individuare eventuali categorie inizialmente non previste come è accaduto per le risposte relative al Supermercato Kalimero.
Considerando le peculiarità della ricerca, la scelta delle domande chiuse, inoltre, è stata preferita per i seguenti motivi:
Consideriamo ora i contenuti del questionario ossia gli aspetti di una intervista suscettibili di essere sviluppati in un modello di rilevazione. Essi possono essere classificati come segue:
Nella determinazione del contenuto del questionario si sono tenute presenti alcune regole empiriche per evitare errori grossolani. Il rispetto di esse può essere considerato condizione necessaria, ma non sufficiente, per preparare un questionario efficace; infatti, oltre ad evitare di commettere gli errori più diffusi, occorre centrare i temi di ricerca in modo da ottenere risposte esaurienti e traducibili in decisioni operative.
Prima di tutto si sono evitate formulazioni generiche e richieste di opinioni su alternative solo genericamente specificate; si tratta in generale di rifuggire da indicazioni che lascino ampi margini di dubbio. Ad esempio, nella domanda "Quante volte si è recata nell’ufficio competente?" non è precisata la estensione del tema considerato; la domanda è stata quindi trasformata in "Per completare ciò che le occorreva, quante volte si è recata nell’ufficio competente?".
Dopo aver accertato che situazioni, conoscenze, comportamenti e problemi considerati rientravano pienamente nella cultura degli intervistati, ampi sforzi sono stati fatti per rendere il significato di ogni domanda univocamente comprensibile a tutti gli intervistati del campione. Quando predisponiamo un questionario siamo spesso portati a fare più o meno implicitamente riferimento alla nostra esperienza personale e diamo per scontato che il significato che noi attribuiamo a una parola sia uguale a ciò che tutti gli altri intendono con il medesimo termine. Il vocabolario di chi prepara questionari deve essere ridotto ad un patrimonio di pochi termini di uso corrente, non ambigui o di incerta preparazione. Non ha senso fare impressione ricorrendo a parole inusuali, dal momento che ciò che conta è che il contenuto della domanda venga pienamente recepito.
Durante la rilevazione, in effetti, non si sono verificati problemi di cognizione terminologica e se si analizza il questionario, gli unici termini che avrebbero potuto dare problemi di comprensione sono "recarsi" ed "erogare" relativi alle domande 6. e 13.
Alla semplicità va associata la brevità: frasi prolisse rischiano di confondere chi deve rispondere. Tutte le domande del questionario sono molto brevi con l’eccezione della 7., 15. e 17. : in questi casi si è preferito allungare di poco le frasi per rendere più chiaro il quesito. Le domande complesse sono state spezzate in più parti dedicate ad un argomento specifico, cui si possa rispondere immediatamente e univocamente. Ad esempio, la seguente domanda: "Le hanno fatto compilare dei moduli, e nel caso, tali moduli erano chiari e facilmente comprensibili?", sicuramente avrebbe disorientato la maggior parte degli utenti, che avrebbero potuto decidere di limitarsi a rispondere solo alla seconda domanda. La sostituzione con le domande 8., 8.a e 8.b è stata d’obbligo anche se ha allungato il questionario che, comunque, si è limitato ad indagare i temi centrali del fenomeno evitando di includere elementi non indispensabili.
Quando il questionario diventa troppo lungo l’attenzione e l’interesse dell’intervistato non si mantengono elevati per molto tempo per cui le parti finali del questionario tendono a ricevere risposte meno approfondite e più frettolose, quindi meno utili delle prime.
Sulla base di questo presupposto, le domande relative alla situazione anagrafica e professionale sono state poste alla fine del questionario.
Tale scelta è maturata anche da considerazioni di ordine psicologico. Considerando che la rilevazione, nel nostro caso, è avvenuta nei pressi degli uffici comunali, l’immediata richiesta di notizie anagrafiche avrebbe potuto produrre un certo sospetto ed una inconscia tensione psicologica nell’utente con l’effetto di renderlo restio a fornire indicazioni temendo un loro utilizzo, per esempio, a fini fiscali. Si è ritenuto opportuno differire le domande di questo tipo alle fasi conclusive della conversazione quando si dovrebbe essere definitivamente stabilito un clima di collaborazione.
Nella pratica della rilevazione, anche con gli accorgimenti sopra elencati e con la rassicurazione della assoluta riservatezza dei dati, molti utenti non hanno voluto rispondere alla domande anagrafiche o hanno risposto in maniera volutamente errata.
La motivazione del comportamento va ricercata nella immotivata paura degli intervistati di essere riconosciuti ( soprattutto dagli addetti al servizio) sulla base degli indizi di carattere personale, vista la dimensione demografica del Comune di Troia. Per motivi analoghi una alta percentuale di utenti non ha voluto ricordare se gli addetti indossavano o meno il tesserino di riconoscimento.
In generale le domande del questionario non hanno richiesto all’intervistato un forte sforzo di memoria tale da produrre distorsioni nella risposta. Si possono distinguere due tipi di errori di memorizzazione, che talvolta operano in direzioni opposte. Il primo consiste nel dimenticare completamente un episodio; l’altro nella compressione del tempo intercorso da un evento, che pertanto è avvicinato al presente (effetto telescopico).
Nella nostra indagine sono stati esclusi entrambi gli errori invitando gli utenti a rispondere alle domande del questionario immediatamente dopo l’utilizzo del servizio. Una sola eccezione è costituita dalla domanda 10. "In media, quante volte al mese si reca in Comune ?" : vista la metodologia campionaria utilizzata, non è stato possibile applicare altre tecniche per ottenere la stessa informazione (checklist, diari, …) se non quella di porre i quesiti di carattere generale dopo quelli di carattere particolare.
Se si considera la sequenza logica delle domande, infatti, si noterà una struttura a "imbuto rovesciato": le domande specifiche precedono quelle più generali che in un secondo momento ampliano il campo di indagine.
Un ultimo aspetto a cui si è fatto molta attenzione è rappresentato dall’influenza che la formulazione di una domanda ha sulla risposta (domande orientate). Bisogna usare molta cura nella fase di impostazione per evitare che anche solo implicitamente alcune risposte siano presentate come più accettabili di altre.
Alcuni ricercatori americani, dopo aver analizzato molte interviste, hanno concluso che nelle domande più ricorrenti di questo genere erano presenti elementi connessi con concetti di "aspettativa" e di "premessa". Nella pratica è difficile riuscire a formulare una domanda che non dipenda da qualche premessa.
Se la premessa è scorretta risulta più facile, per chi deve rispondere, correggere una domanda aperta rispetto a una chiusa, dal momento che la prima consentirà di rispondere più liberamente attenuando l’influenza della premessa.
Nel nostro caso, oltre all’uso di uno schema a domande chiuse, è presente un’altra aggravante dell’effetto influenza: la visione politica dei partecipanti alla ricerca. Non dimentichiamo che i comuni sono governati da organi politici che potrebbero dare alla ricerca un certo indirizzo ideologico. Per evitare ogni tipo di influenza della formulazione della domanda sulla risposta degli utenti:
Per dare una idea di come la formulazione di un quesito può orientare la risposta, consideriamo la domanda 15. del questionario e trasformiamola nella seguente "Già gli uffici comunali sono aperti di pomeriggio il martedì ed il giovedì; sarebbe utile aumentare i giorni di apertura pomeridiana?". E’ evidente come il termine "Già" posto all’inizio della frase induca l’utente ad una risposta negativa soprattutto, poi, se l’intervistatore pone un particolare accento proprio sulla premessa. Non provoca lo stesso effetto l’avverbio realmente utilizzato (solo) che è stato inserito nella premessa della domanda 15. per indicare, ai meno informati, che gli uffici erano aperti il martedì ed il giovedì e non gli altri giorni della settimana.